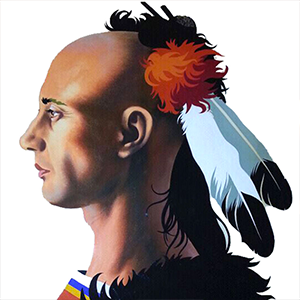Gilberto Zorio, Esordio e canoe 1967-2000
Prima mostra di Zorio alla Galleria Sperone, testo TT (1967). Di fronte all’opera di Zorio è inutile ricorrere agli schemi correnti, ultimissimi compresi. La nuova scultura, anche quella più elementare, appare molto concettuale rispetto a questo esordio nuda, totalmente fisico. Problemi di spazio, di forma, di struttura? No, poiché qui è facile constatare che: le masse hanno poco a che fare con lo spazio ambiente, le forme sono il passivo risultato di un’azione, e gli insiemi in cui ogni singolo pezzo si configura possono essere considerati come “de-strutture”. Zorio presenta un gruppo di lavori che mostrano l’azione e lo spettacolo di alcune leggi fisiche tanto elementari quanto assurde. Finalmente, ho visto degli oggetti dove i materiali, la materia, significano energia. Dopo Zorio, l’inerzia e la stasi di altre costruzioni si rivelano ancora più fittizie e superficiali. Qui troviamo invece la rappresentazione di una tensione continua. Ecco un tubo di eternit in bilico sopra delle camere d’aria; o un battacchio di cemento pendere come una spada di Damocle sul morbido poliuretano; o alcuni elementi tubolari torcersi e tendersi nonostante siano immobili, e lavorati con distacco. Zorio pare percepire in termini di massa energia continua. Ecco altri lavori che presentano lo svolgersi di tale fatto: l’acqua salata che è sul telo indica una forza che preme, ma rimane assorbita e contenuta; il blocco cilindrico di cemento si è sfaldato sotto il suo peso, senza contaminare la superficie che lo riceve. L’azione con cui Zorio s’impossessa delle cose del mondo è anche quella che trasforma il loro stato fisico in un altro. La sua energia resta visibilmente conservata nel lavoro – in uno spettacolo di energia potenziale. Leggi
Maurizio Mochetti, mostra all’Ariete, 1969
| Presentazione TT (1969). Sono presentate a Milano tre nuove opere del romano Maurizio Mochetti che si aggiungono alle due esposte lo novembre scorso alla Salita di Roma, nella personale che ha rivelato il suo nuovo lavoro e imposto subito una presenza inconfondibile. Risale al ‘65 la prima intuizione che ha maturato l’attuale lavoro: al progetto di presentare un raggio di sole in un ambiente oscuro […] Le difficoltà incontrate da Mochetti non riguardano mai la progettazione o la realizzazione, ma piuttosto la comunicazione. I suoi lavori si negano generalmente a ogni forma di comunicazione che non sia la loro diretta esperienza; non solo perchè difficilmente fotografabili – talora a causa dei loro micro-movimenti – ma anche perché si presentano come pura informazione. Mochetti sta lavorando a progetti futuribili perché non è stata ancora perfezionata la tecnologia a loro necessaria. Per lui accade quel che sta succedendo alle esperienze comportamentali di azione o di concetto, in apparenza opposte alle sue che sono così costruttive: si tratta di lavorare sul controllo dell’informazione. Questa inclinazione cibernetica pare identificarsi con il controllo artistico. […] Leggi |
A proposito di John Cage, 2007
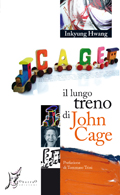 “Prefazioso” per Hwang Inkyung, testo TT (2007). Fare, non fare, pensare, non pensare: sono atti speculari, di cui il negativo è solo un simulacro del positivo. Tra loro non c’è vera differenza, ma dialettica; la differenza sta tra i diversi specchi. Prendiamo il silenzio che succede alla creazione, quale fu simulato da Marcel Duchamp nella seconda parte della sua esistenza. E accostiamolo al silenzio musicale, inscenato mentre la musica è comunque attuata, sia pure insonorizzata, certo in differita, quale fu invece materializzato come durata da John Cage, suo carismatico seguace. Duchamp, maestro di attimi, mi parla. Il suo seguace mi fa parlare: ma di che, scusi? Ecco, Cage, lo dice il nome, mi ingabbia. Non si collocò a lungo fra i miei maestri.
“Prefazioso” per Hwang Inkyung, testo TT (2007). Fare, non fare, pensare, non pensare: sono atti speculari, di cui il negativo è solo un simulacro del positivo. Tra loro non c’è vera differenza, ma dialettica; la differenza sta tra i diversi specchi. Prendiamo il silenzio che succede alla creazione, quale fu simulato da Marcel Duchamp nella seconda parte della sua esistenza. E accostiamolo al silenzio musicale, inscenato mentre la musica è comunque attuata, sia pure insonorizzata, certo in differita, quale fu invece materializzato come durata da John Cage, suo carismatico seguace. Duchamp, maestro di attimi, mi parla. Il suo seguace mi fa parlare: ma di che, scusi? Ecco, Cage, lo dice il nome, mi ingabbia. Non si collocò a lungo fra i miei maestri.
E’ il Creatore che riposa dopo la creazione, tacendo. Duchamp, che mai si diede al silenzio, se non quello di una partita di scacchi, passò dal giorno alla notte, dalla notte all’alba, affidando la sua opera ai vari cicli diuturni. Aveva creato un mondo ready-made e non volle che proliferasse, avendo orrore dei futuri Arman; né che infrangesse, più del vetro, le precise leggi che ne reggono l’evoluzione; e lo lasciò annottare e poi rinascere. Al contrario, il musicista Cage levò un giorno le mani dai suoni e dai pianoforti, dei quali sabotava le corde, e sospese i suoni ma non la musica: fu giocoforza chiamarla silenzio. A volte, esibì il silenzio in prima persona, davanti a tutti, chiedendo silenzio al coro, in un generale s/concerto; più spesso, tornò a comporre. Le sue leggendarie performance che non hanno secondi fini, né spirituali né fideistici, sono minuti di liturgia dell’ascolto di sé. Molto diverse, dunque, dall’ascolto del sacro in cui si immergono, io suppongo, i monaci trappisti; e dalla meditazione zen che oltrepassa anche il sacro per inoltrarsi nel vuoto. A Cage diedero sostegno lo Zen, nonché il Tao, nella fattispecie del wu wei, il non-agire. Mi spiace che li abbia tradotti in una sbrigativa pausa una tantum della liturgia del conta minuti. Leggi
Alberto Allegri – “Alfascultura dell’io” (2003)
Due anni fa, era il 2001, Alberto Allegri ha cominciato a scrivere la parola IO in una serie di tavole e sculture. Dapprima, in carattere bodoni, un bell’IO tondo con tutte le grazie tipografiche; poi in corsivo e minuscolo con grazie alla Parmigianino, che è visibile lì a Fontanellato, poco distante dal suo studio; e quindi in stile birichino, cioè al modo aereo di Allegri e tutte le sue passate sculture. IO è il pronome personale, prima persona singolare, che tu, egli, noi usiamo tutti i giorni. Può capitare di porre una tavola al rovescio e di leggervi OI – allora il pronome diventa una data, il primo anno del primo secolo del terzo millennio. Niente ha più prospettive del nostro ego. […]
Evoca l’attualità della Via Francigena medievale, quest’opera di Alberto Allegri, che mira a installarvi sei sculture, le sei lettere di Europe, in altrettante tappe fra Roma e Canterbury – più una. Eccola, la secolare via di comunicazione che è cresciuta dallo sterrato alle pietre, dal pavé all’asfalto, inoltrandosi tra la Chiesa Cattolica e le altre Chiese, attraverso nazioni nemiche: sta ancora lì. Passa presso la casa dell’artista. Con poche altre, sarà, di volta in volta, la strada santa dei pellegrini, l’autostrada degli eserciti imperiali, la deserta landa dei predoni, e il cannocchiale trafficato dei sapienti.
L’opera di Alberto Allegri si colloca su questi crinali liquidi. E’ una scultura che si fa al tempo stesso scrittura; e una scrittura che diventa architettura nello spazio fisico. Pone l’io al posto del punto di fuga, che nella prospettiva classica equivaleva a zero. […] Conviene definirla alfascultura, l’arte di Alberto Allegri, per la buona ragione che sa leggere e riprodurre la lettera dei fenomeni visibili allo scopo di mutarne lo spirito, e in tal senso mi pare più prossima alla riproduzione digitale che a quella analogica, a differenza dell’arte scritta, generalmente dipinta, che riposa sulle analogie pittoriche dei segni verbali. Inoltre, c’è una bella differenza, per venire a questo ciclo dell’IO, con le sole altre opere egoiche che mi vengono alla mente: le tavole su cui il fluxus Ben Vautier sciabola tuttora la parola “ego”, per dire che l’arte è solo egocentrismo. […] A dire il vero, l’alfascultura di Allegri fa più di un’incursione nell’orto letterario: lo sfida. Nella sua contiguità alla scrittura, essa rilancia il tema della sua autonomia. Una scrittura allevata dalla scultura è figlia delle arti visive più che della letteratura? Le lettere disegnate e scolpite da Allegri sono un principio di architettura letterale. Potere alzare un’architettura di lettere e parole, ma pur sempre di pietra o metallo, consente allo scultore Allegri di essere, avendo la possibilità di realizzarla, un eccellente e fattivo alleato dell’architettura costruita. [Tommaso Trini, 2003]